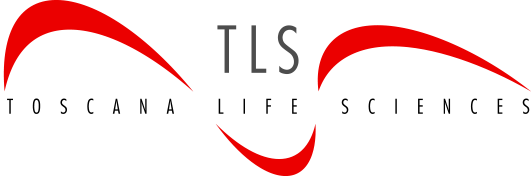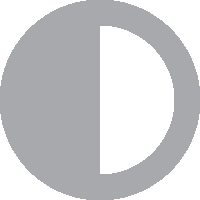Fino a poco tempo fa, la ricerca universitaria era un mondo a sé. Troppo ancorata alla ricerca pura, allergica ad ogni contaminazione con l’industria, vedeva altezzosamente dall’alto il mondo delle imprese. Se un ricercatore aveva un’idea, la sua priorità era pubblicare un saggio, un articolo, un report. Negli Stati Uniti il percorso era esattamente l’opposto; se un ricercatore universitario aveva un’idea, la priorità era arrivare al brevetto e poi, eventualmente, pubblicare. Così fare ricerca non premiava nessuno e all’interno dell’università si deprimeva chi cercava legami con le industrie.
Oggi qualcosa sta cambiando; le incrostazioni che hanno impedito l’osmosi benefica tra università e imprese stanno per essere rimosse. Il primo fattore di cambiamento è il taglio ai finanziamenti statali per le università. Cosa che ha spinto una nuova generazione di rettori, molti dei quali cinquantenni, a cercare altre strade per avere fondi. Da qui i rapporti diretti con le imprese, gli accordi con i ricercatori e distretti produttivi, una corsa più accelerata a brevettare le scoperte nei laboratori universitari. Anche tra i giovani studenti e ricercatori tutto è cambiato. Se dieci anni fa chi si metteva in proprio e creava una piccola azienda era visto con sospetto, oggi sono tante le start up nate all’interno delle università. Germinate anche grazie a una delle migliori leggi in Europa sulle imprese innovative: sono già 3100 le start up iscritte all’albo, che godono di una burocrazia più semplice, di una defiscalizzazione accentuata e possono trovare finanziamenti con un crowdfunding rivoluzionario, evitando di incappare nei vincoli di Consob e autorità monetarie. Creare una start up oggi non è solo sexy, svolge anche una sezione sociale positiva, con la nascita di un’impresa. Attorno ai Politecnici di Torino e di Milano, lungo l’asse da Firenze a Pisa, sono nati poli biotecnologici e di innovazione che hanno seminato tante imprese, spin off universitari, aziende che hanno all’orizzonte persino le quotazioni in Borsa.
Dalle università alle colpe delle imprese, il passo è breve. In Italia abbiamo avuto un periodo troppo lungo con l’innovazione industriale fatta solo dalla grande azienda. La quale generava le imprese della filiera, create da tecnici e dirigenti dell’azienda madre. Un modello andato in crisi con il declino della grande industria; e il nuovo sistema stenta ancora a vedere la luce. Altro nodo irrisolto, i finanziamenti. La forza del modello Harvard, Boston e San Francisco, è il venture capitalism: ti finanziavano qualunque idea, ma controllavano i progressi e i fondi arrivavano solo raggiungendo le milestone, le tappe prefissate del progetto. E’ il controllo che è mancato all’esperienza italiana; in troppi casi soldi pubblici o di finanziamenti bancari hanno finanziato idee innovative, che hanno prodotto risultati, a parte lo spreco di denaro. L’esempio di Siena Biotech, 150 milioni di euro stanziati senza tenere i cordoni della borsa legati ai risultati della ricerca, hanno prodotto il collasso della struttura e il fallimento di una giusta intuizione. Recuperata, poi, grazie ad altre forme societarie. Per questo oggi penso che il modello Harvard possa essere replicato anche in Italia. Farà solo più fatica a nascere.
Fabrizio Landi, presidente di Toscana Life Sciences